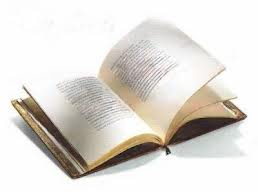 Carla aveva la patente ma non portava l’auto di frequente. Roberto voleva sempre guidare lui e considerava le donne al volante un pericolo. Lei non era abituata alla guida e lo faceva solo in casi estremi, per necessità o addirittura di nascosto del marito. Ormai molte cose le faceva senza dirlo al marito, per paura di irritarlo. Era iroso, sospettoso, nervoso. Nel mese di giugno, quando avevo da poco compiuto otto anni, andai a trascorrere dei giorni di vacanza in una colonia estiva di montagna. Non mi trovavo bene nelle colonie, perché ero molto chiusa. Amavo starmene in disparte a comporre poesie o a disegnare. Era cresciuta sempre sola e ora non sapevo organizzare i giochi di società. Non sapevo stare nel gruppo. Gli altri mi intimidivano. Non sopportavo la competizione che subito si creava. Non riuscivo ad entrare in relazione con gli altri. Alcune compagne dicevano male di me, denigravamo le mie poesie, alcune giunsero persino a strapparle. Alcune amiche mi accusavano di superbia, scambiavano la mia timidezza, i miei silenzi per senso di superiorità. Le mie poesie per loro non valevano niente. Alcune amiche dicevano per invidia che anche loro scrivevano poesie. Odiavo la montagna, infatti essendo pigra detestavo le escursioni. Le gite, le passeggiate mi affaticavano, mi snervavano. Preferivo di gran lunga il mare che mi permetteva di oziare sulla spiaggia. Le mie vacanze venivano decise da mio padre. Finita quella vacanza io non vedevo l’ora di tornare a casa. Venne a riprendermi mia madre, perché mio padre e mio fratello erano in Brasile. Lei preferì venire con l’auto di famiglia, la grande macchina di papà. Era orgogliosa di guidare quell’auto, che aveva pochi mesi di vita. La guidava con spavalderia, sicura di sé. Nel viaggio di ritorno i tornanti montani erano molti. Ci trovammo di fronte a ripide discese e a curve pericolose. Carla prese una curva a forte velocità e uscì di strada. L’auto si capovolse completamente, nessuno era presente. L’incidente non aveva coinvolto altre auto. Io ricordo solo un colpo forte e un dolore intenso negli arti inferiori, poi svenni. Mia madre riuscì a tirarsi fuori dal finestrino, ma aveva molte contusioni, una gamba rotta, la testa sanguinante, un braccio fratturato. Era veramente malridotta ma il suo primo pensiero fu per mio padre, già immaginava le sue urla. Tentò di soccorrermi ma poi svenne anche lei per la tensione nervosa. Per fortuna passò di là un automobilista che avvisò le autorità e prestò i primi soccorsi. Fummo portate al vicino ospedale poi io fui trasferita, date le mie condizioni, con un elicottero nella capitale. Non c’era tempo da perdere. Mia madre fu subito operata alla testa e ingessata. Quando Roberto rientrò dal Brasile ci furono scenate incredibili. Arrivò persino ad aggredire sua moglie davanti a tutti. La accusò di essere troppo distratta e incurante del pericolo. Inoltre la sua preziosa e costosa auto era andata distrutta. Anche io fui operata ma senza risultato. Il verdetto dei medici fu terribile: paralisi completa agli arti inferiori. Nessuna riabilitazione poteva ridarmi l’uso delle gambe. Ero condannata a non camminare più. A vita, per sempre, non avrei camminato più. C’era da impazzire. Non me lo dissero subito ovviamente, mi illusero per diverso tempo. I parenti accorsi al nostro capezzale trovarono tutti da ridire e non fecero altro che criticare. La maggior parte accusarono mia madre di leggerezza. Era sempre stata una sventata, inaffidabile, viziata. Era accaduta una disgrazia ma nessuno ci diceva una sola parola di conforto. Nessuno pensò di aiutarci concretamente. Molti parenti quando compresero il mio stato si dileguarono. Temevano un loro coinvolgimento nella faccenda. Io ormai ero una handicappata a tutti gli effetti, avevo l’infame marchio di diversa, solo che io non lo sapevo. Molti parenti osarono dire che andavo messa, parcheggiata in un istituto. Dovevano sbarazzarsi di me. Dovevo sparire. Non ero degna di stare nella società civile fra la gente normale. Questa società ti accetta se sei attivo, efficiente, ma quando devi dipendere dagli altri sei escluso, tagliato fuori. Molti zii così cercarono di convincere mio padre a mandarmi in un istituto. Solo mia madre si oppose con determinazione. Lei voleva darmi calore, affetto, consolazione, quello che in istituto non potevo avere nemmeno per tutto l’oro del mondo. Carla voleva tenermi sotto la sua protezione, sotto il suo occhi vigile di madre scrupolosa. Non ero più autosufficiente e chiunque poteva approfittarsi di me, soprattutto in istituto. Ero un fiore fresco reciso, calpestato dal destino, senza un ruolo, senza prospettive, alla deriva. Dovevo vivere il resto dei miei giorni sotto una campana di vetro e guardare il frastuono del mondo da un angolo buio. Ora più che mai avevo bisogno del calore di una vera famiglia, di uno scudo protettivo per difendermi dalle insidie del mondo. Potevo essere il bersaglio di chiunque. Il mondo era crudele nonostante le apparenze. Ripensavo alle crudeltà dell’asilo, delle colonie, dei parenti. Il mondo fuori mi attendeva con le sue ipocrisie, le sue piccole e grandi violenze quotidiane. I primi giorni di degenza furono tremendi. Avevo il tiraggio alle gambe, il braccio ingessato, gli occhi appannati, coperti da un velo, a stento distinguevo le persone intorno a me. Mi venne una febbre divorante, bruciante. Sudavo continuamente e mi lamentavo per i dolori alle ossa, le gambe non me le sentivo più. Quando domandavo agli infermieri il perché di questa mancanza di sensibilità, loro mi guardavano con un’aria di compatimento, facevano gesti fra loro ma io non capivo, non volevo capire. Di solito non si vuole mai accettare una realtà dolorosa. Quando la vita ci mette con le spalle al muro ci ribelliamo, siamo riluttanti ad accettare il giogo. I filosofi greci dicevano che gli dei hanno dato agli uomini “le cieche speranze” per poter sopportare meglio i mali del mondo. Io speravo in cuor mio che mi sarei ripresa e che tutto sarebbe filato liscio. Pensavo che quella malattia, che mi costringeva a letto, fosse transitoria. Come mi illudevo! In realtà ero in trappola, bloccata per sempre, con le ali tarpate, costretta all’immobilità per il resto della vita. C’era da diventare pazzi. Carla ormai era fuori di sé, logorata dal senso di colpa, lacerata nell’anima. In quei giorni di calvario solo mia madre era vicina. Mi dava coraggio, mi tirava su il morale, mi faceva ridere con delle battute.
Carla aveva la patente ma non portava l’auto di frequente. Roberto voleva sempre guidare lui e considerava le donne al volante un pericolo. Lei non era abituata alla guida e lo faceva solo in casi estremi, per necessità o addirittura di nascosto del marito. Ormai molte cose le faceva senza dirlo al marito, per paura di irritarlo. Era iroso, sospettoso, nervoso. Nel mese di giugno, quando avevo da poco compiuto otto anni, andai a trascorrere dei giorni di vacanza in una colonia estiva di montagna. Non mi trovavo bene nelle colonie, perché ero molto chiusa. Amavo starmene in disparte a comporre poesie o a disegnare. Era cresciuta sempre sola e ora non sapevo organizzare i giochi di società. Non sapevo stare nel gruppo. Gli altri mi intimidivano. Non sopportavo la competizione che subito si creava. Non riuscivo ad entrare in relazione con gli altri. Alcune compagne dicevano male di me, denigravamo le mie poesie, alcune giunsero persino a strapparle. Alcune amiche mi accusavano di superbia, scambiavano la mia timidezza, i miei silenzi per senso di superiorità. Le mie poesie per loro non valevano niente. Alcune amiche dicevano per invidia che anche loro scrivevano poesie. Odiavo la montagna, infatti essendo pigra detestavo le escursioni. Le gite, le passeggiate mi affaticavano, mi snervavano. Preferivo di gran lunga il mare che mi permetteva di oziare sulla spiaggia. Le mie vacanze venivano decise da mio padre. Finita quella vacanza io non vedevo l’ora di tornare a casa. Venne a riprendermi mia madre, perché mio padre e mio fratello erano in Brasile. Lei preferì venire con l’auto di famiglia, la grande macchina di papà. Era orgogliosa di guidare quell’auto, che aveva pochi mesi di vita. La guidava con spavalderia, sicura di sé. Nel viaggio di ritorno i tornanti montani erano molti. Ci trovammo di fronte a ripide discese e a curve pericolose. Carla prese una curva a forte velocità e uscì di strada. L’auto si capovolse completamente, nessuno era presente. L’incidente non aveva coinvolto altre auto. Io ricordo solo un colpo forte e un dolore intenso negli arti inferiori, poi svenni. Mia madre riuscì a tirarsi fuori dal finestrino, ma aveva molte contusioni, una gamba rotta, la testa sanguinante, un braccio fratturato. Era veramente malridotta ma il suo primo pensiero fu per mio padre, già immaginava le sue urla. Tentò di soccorrermi ma poi svenne anche lei per la tensione nervosa. Per fortuna passò di là un automobilista che avvisò le autorità e prestò i primi soccorsi. Fummo portate al vicino ospedale poi io fui trasferita, date le mie condizioni, con un elicottero nella capitale. Non c’era tempo da perdere. Mia madre fu subito operata alla testa e ingessata. Quando Roberto rientrò dal Brasile ci furono scenate incredibili. Arrivò persino ad aggredire sua moglie davanti a tutti. La accusò di essere troppo distratta e incurante del pericolo. Inoltre la sua preziosa e costosa auto era andata distrutta. Anche io fui operata ma senza risultato. Il verdetto dei medici fu terribile: paralisi completa agli arti inferiori. Nessuna riabilitazione poteva ridarmi l’uso delle gambe. Ero condannata a non camminare più. A vita, per sempre, non avrei camminato più. C’era da impazzire. Non me lo dissero subito ovviamente, mi illusero per diverso tempo. I parenti accorsi al nostro capezzale trovarono tutti da ridire e non fecero altro che criticare. La maggior parte accusarono mia madre di leggerezza. Era sempre stata una sventata, inaffidabile, viziata. Era accaduta una disgrazia ma nessuno ci diceva una sola parola di conforto. Nessuno pensò di aiutarci concretamente. Molti parenti quando compresero il mio stato si dileguarono. Temevano un loro coinvolgimento nella faccenda. Io ormai ero una handicappata a tutti gli effetti, avevo l’infame marchio di diversa, solo che io non lo sapevo. Molti parenti osarono dire che andavo messa, parcheggiata in un istituto. Dovevano sbarazzarsi di me. Dovevo sparire. Non ero degna di stare nella società civile fra la gente normale. Questa società ti accetta se sei attivo, efficiente, ma quando devi dipendere dagli altri sei escluso, tagliato fuori. Molti zii così cercarono di convincere mio padre a mandarmi in un istituto. Solo mia madre si oppose con determinazione. Lei voleva darmi calore, affetto, consolazione, quello che in istituto non potevo avere nemmeno per tutto l’oro del mondo. Carla voleva tenermi sotto la sua protezione, sotto il suo occhi vigile di madre scrupolosa. Non ero più autosufficiente e chiunque poteva approfittarsi di me, soprattutto in istituto. Ero un fiore fresco reciso, calpestato dal destino, senza un ruolo, senza prospettive, alla deriva. Dovevo vivere il resto dei miei giorni sotto una campana di vetro e guardare il frastuono del mondo da un angolo buio. Ora più che mai avevo bisogno del calore di una vera famiglia, di uno scudo protettivo per difendermi dalle insidie del mondo. Potevo essere il bersaglio di chiunque. Il mondo era crudele nonostante le apparenze. Ripensavo alle crudeltà dell’asilo, delle colonie, dei parenti. Il mondo fuori mi attendeva con le sue ipocrisie, le sue piccole e grandi violenze quotidiane. I primi giorni di degenza furono tremendi. Avevo il tiraggio alle gambe, il braccio ingessato, gli occhi appannati, coperti da un velo, a stento distinguevo le persone intorno a me. Mi venne una febbre divorante, bruciante. Sudavo continuamente e mi lamentavo per i dolori alle ossa, le gambe non me le sentivo più. Quando domandavo agli infermieri il perché di questa mancanza di sensibilità, loro mi guardavano con un’aria di compatimento, facevano gesti fra loro ma io non capivo, non volevo capire. Di solito non si vuole mai accettare una realtà dolorosa. Quando la vita ci mette con le spalle al muro ci ribelliamo, siamo riluttanti ad accettare il giogo. I filosofi greci dicevano che gli dei hanno dato agli uomini “le cieche speranze” per poter sopportare meglio i mali del mondo. Io speravo in cuor mio che mi sarei ripresa e che tutto sarebbe filato liscio. Pensavo che quella malattia, che mi costringeva a letto, fosse transitoria. Come mi illudevo! In realtà ero in trappola, bloccata per sempre, con le ali tarpate, costretta all’immobilità per il resto della vita. C’era da diventare pazzi. Carla ormai era fuori di sé, logorata dal senso di colpa, lacerata nell’anima. In quei giorni di calvario solo mia madre era vicina. Mi dava coraggio, mi tirava su il morale, mi faceva ridere con delle battute.